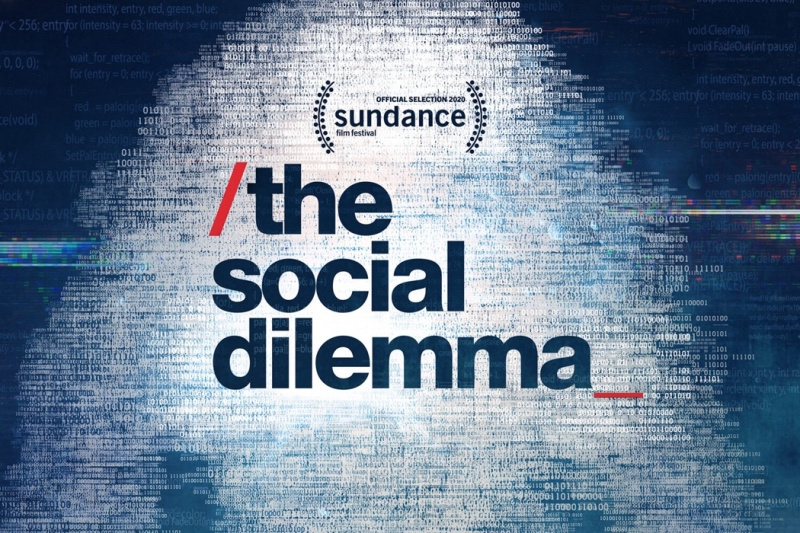
“Ci sono solo due settori in cui il cliente viene chiamato ‘utente’: le droghe e il software.” (Edward Tufte, esperto di statistica). Non servono effetti speciali per farci riflettere. “The Social Dilemma”, documentario esclusivo di Netflix, ci riesce con una semplicità disarmante e un pugno nello stomaco. A parlare sono gli stessi ingegneri, designer ed ex dirigenti delle Big Tech: quelli che la “macchina” l’hanno costruita. E ora ci avvertono del suo impatto.
Un documentario inquietante ma necessario, da guardare (e far guardare), soprattutto alle nuove generazioni: https://bit.ly/tobedigital-socialdilemma.
Il problema non sono i social. È il loro scopo.
Il ritratto che ne emerge è quello di una società iperconnessa ma profondamente disorientata. Il confine tra realtà e virtuale si assottiglia, fino a scomparire. Creiamo versioni perfette (e irreali) di noi stessi, mentre l’algoritmo ci isola dentro bolle che ci rassicurano, ci polarizzano e – soprattutto – ci profilano.
Nel tempo di un clic, un bot può diffondere un’informazione in milioni di feed, generando un effetto domino impossibile da fermare. Il tempo di riflettere? Azzerato. La comunicazione ha superato la nostra capacità di comprenderla.
La dipendenza silenziosa
Siamo connessi 24/7. Il nostro cervello, no. Ecco il vero conflitto: mentre l’intelligenza artificiale evolve in modo esponenziale, la nostra mente resta biologicamente quella di sempre. Vulnerabile. Soprattutto nei più giovani.
Lo scroll infinito, il tasto “aggiorna”, i tre puntini di WhatsApp… sono solo esempi di “rinforzo positivo intermittente”, lo stesso principio delle slot machine. Il risultato? Una scarica di dopamina ogni volta che riceviamo una notifica. Una dipendenza silenziosa, ma reale.
Anna Lembke, docente di Medicina delle Dipendenze a Stanford, lo dice chiaramente: “I social media sono una droga che agisce direttamente sul sistema della dopamina.”
Chi è il vero pusher?
La domanda, oggi, non è più “Come usciamo da questo sistema?”, ma “Chi lo alimenta?”
La risposta è scomoda: noi. O meglio, i nostri dati, i nostri comportamenti, i nostri desideri. Perché se qualcosa è gratis, significa che il prodotto siamo noi.
Lo spiega bene Roger McNamee, uno dei primi investitori in Facebook: “Durante i primi 50 anni la Silicon Valley vendeva prodotti. Ora vende utenti.”
Ed è proprio qui che cambia tutto: non siamo più clienti, siamo merce. La più preziosa di tutte: consapevole, profilata, influenzabile.
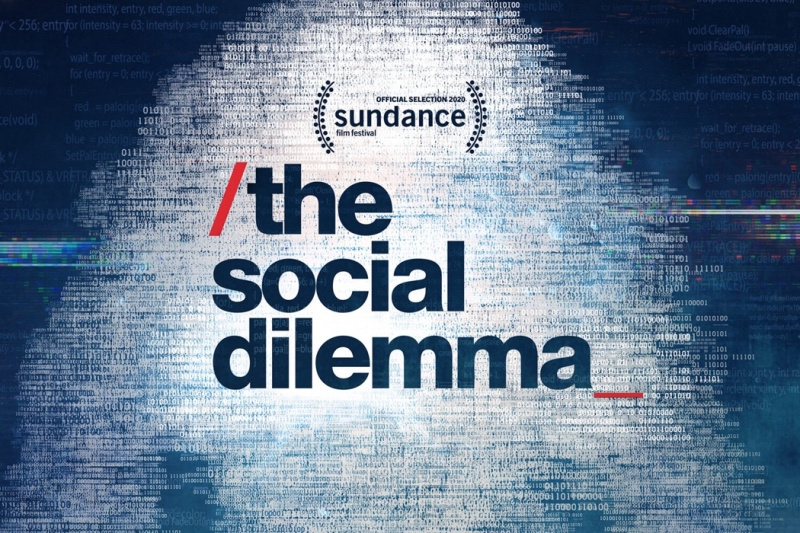
Il valore del tempo (rubato)
L’obiettivo delle piattaforme non è più vendere contenuti, ma catturare la nostra attenzione. Il tempo è diventato la valuta più ambita. “Vendiamo il nostro tempo, ma nessuno ce lo paga”, scrive Sergio Bellucci nel suo saggio L’industria dei sensi. E ha ragione. Perché ogni secondo trascorso online arricchisce qualcun altro.
Ogni app “gratuita” è una miniera d’oro per chi sa scavare nei nostri dati. Dove siamo, cosa facciamo, cosa pensiamo, cosa sogniamo. Informazioni che, combinate, permettono di predire – e quindi manipolare – i nostri comportamenti futuri. Proprio come un “future” finanziario. Solo che, questa volta, il bene su cui si scommette… siamo noi.
Il nuovo potere: chi controlla la Rete, controlla il mondo
Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta. Le prime cinque aziende per capitalizzazione al mondo non producono mais, acciaio o energia. Producono conoscenza – su di noi.
Controllare la rete oggi significa controllare l’economia, la politica, le opinioni. Le guerre non si combattono più con i carri armati, ma con le piattaforme digitali. E senza sparare un colpo, si può conquistare un Paese.
Ecco perché la domanda chiave non è più tecnologica, ma politica:
Chi esercita la sovranità digitale?
Chi decide cosa possiamo vedere?
Chi controlla i dati, gli algoritmi, l’intelligenza artificiale?
Sono interrogativi che, come agenzia, come cittadini, come genitori, non possiamo più ignorare.
Non si tratta di demonizzare la tecnologia. Ma di capirla. Di educare all’uso critico e responsabile, soprattutto i più giovani. Di restituire senso al nostro tempo, e valore alla nostra attenzione.
Perché se la “macchina” è costruita per tenerci incollati, il primo passo per liberarcene… è guardarla negli occhi.
